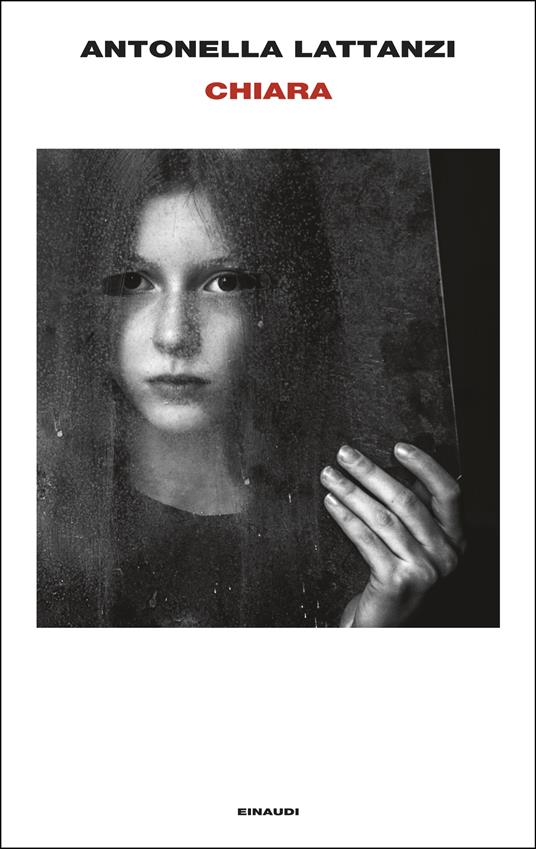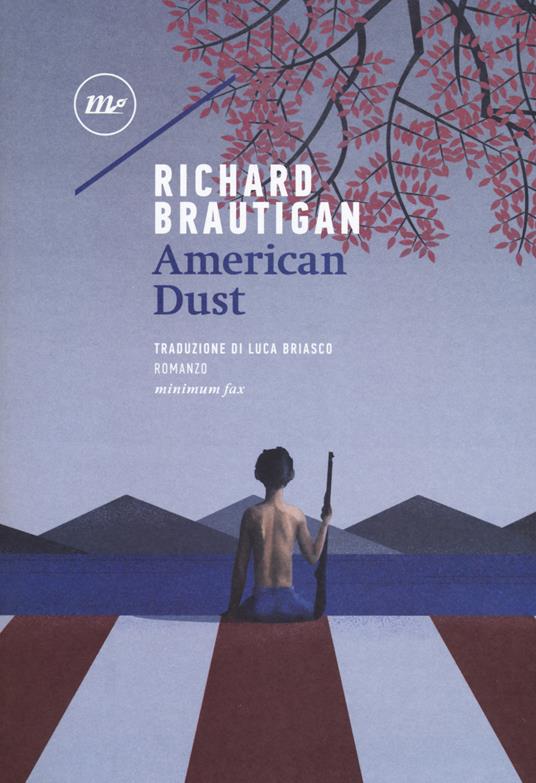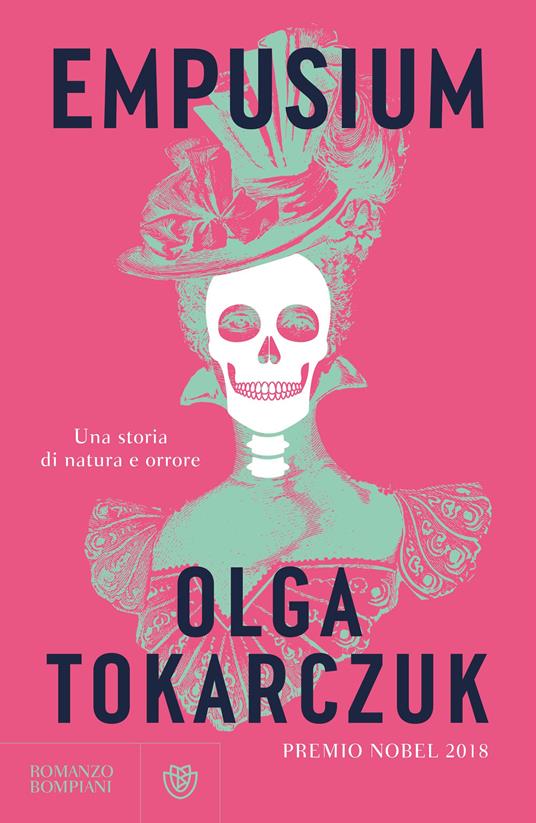Da qualche anno seguo Antonella Lattanzi. In particolare da quando ho deciso di aprire un profilo #instagram dedicato ai libri entrando così a far parte del mondo del #bookstagram. Cosa che fino al 2020, ovvero la pandemia, non avrei mai pensato esistesse. Credo sia strepitoso il fatto di avere un luogo virtuale in cui gli autori intrattengono una relazione quasi reale con il proprio potenziale pubblico di lettori credo sia una grande conquista. Per alcuni autori questa modalità di comunicazione è congeniale.

L’interesse che la Lattanzi è riuscita a suscitare in me forse è dovuto a una sorta di assonanza che per alcuni aspetti mi è sembrato di cogliere. Me ne sono resa conto soprattutto leggendo il suo ultimo romanzo “Cose che non si raccontano”. Alcuni tratti mi sono vicini, quindi la leggo e la ascolto con una certa curiosità affine.
Devozione edito con Einaudi è un romanzo uscito nel 2010 e parla di una coppia di giovani ragazzi vittime della loro stessa smania. Sono prigionieri consenzienti del vortice in cui può gettare l’uso di sostanze o l’abuso di alcool. Soffrono della sindrome di Stoccolma. L’eroina muove tutte le stelle, la fuggono e ricercano senza sosta, con le unghie e tutte le poche energie residue, abdicando dalle proprie aspirazioni. Mi ha colpito molto la descrizione degli ambienti in cui nascono e si muovono come tossici, il linguaggio duplice e parallelo che sembra viaggiare a fianco alla realtà quieta degli altri, amata e odiata, desiderata e rifuggita, questa dicotomia lacera la volontà di Nikita e Pablo i protagonisti. Le scene descritte vorticano e si ripiegano su se stesse, claustrofobiche come il baule della macchina quasi incendiata e che a lungo serpeggia nei loro pensieri e sogni agitando un residuo di umanità. Qui se ne avete voglia potete leggere un #estratto gentilmente offerto Einaudi.
Il linguaggio dell’ambiente, direi “tecnico” e che ci viene progressivamente svelato in tutta la sua crudezza è una forma di sortilegio esso stesso. Conduce oltre una porta, superata questa soglia il ritorno è pressoché improbabile. L’istinto una volta entrati nello sballo è di non farsi più ma poi entrambi, Pablo e Nikita con tutti i loro compagni di sventura, ricadono nella smania, nella “rota” come viene definita e richiamata più e più volte durante la storia. Io ho dovuto cercare il termine qui al punto sei della voce Treccani per capire, le prime volte mi sfuggiva il senso. Sono due anime perse su un ottovolante di cui hanno perso il controllo. Le loro intenzioni e volontà sono annichilite da un bisogno che di biologico e di umano comincia non avere più niente.
Durante le loro serate in cerca di “roba” e “spade” più o meno vergini, si muovono tra persone più morte che vive, spettri che riflettono la loro stessa rovina, finché incrociano Annette. Una ragazza sul ciglio del burrone, pronta a lanciarsi insieme a loro verso una fuga nel nulla, per dimenticare la vita.
Pablo e Nikita accolgono Annette, la adottano, diventano amici per sempre, la portano nei meandri luridi della loro esistenza e piangono l’incapacità di decidere, di tenere il conto dei giorni, di capire di cosa, un essere umano abbia davvero bisogno.
“Nikita e Pablo non sono persone, sono faine. Pescano un residuo di vita in un campo minato di vene avvizzite e le fanno la corte per tutto il tempo necessario”
Non esiste bisogno umano, piacere, cibo, affetto, sogni. Anzi proprio sui sogni si è abbassata una coltre di nebbia spessa, il vuoto di desiderio è una spirale dentro la quale esiste solo la follia e sopportare la vita è l’unica spinta che costringe Pablo e Nikita verso la prossima dose. Ma poi? Consumano le vene, non c’è più posto non c’è più tempo, spazio, corpo. Tutto si mescola nella testa e nel corpo di Nikita. Non sente più niente. Ha piccoli, infinitesimali momenti di lucidità che rischiano di ucciderla e si rifugia nell’oblio dove sembrano sovrapporsi persone, ricordi, passato e presente sguardi e assenze.
Non è stato facile leggere questo romanzo. Alcune scene descritte sono crude al punto che mi hanno dato la nausea. L’obiettivo di Antonella Lattanzi di catapultare il lettore dritto nella vita, nei retroscena e nella bocca della tossicodipendenza è centrato con precisione chirurgica. Lo spirito e la mente di una ragazzina Nikita, Vera, che cresce con un bisogno a cui non riesce a dare un nome. Una giovane donna circondata dall’amore ma che ne coglie le spine, si dissangua prima del tempo e desidera una fuga, cerca la pace.
Le mille varianti, motivazioni, dolori che portano alla tossicodipendenza di una giovane donna sono il paradigma di una vita fallita. Il fallimento qui è congenito, sanguigno, orrendamente assetato di vita. Una larva che si nutre del suo bozzolo distruggendosi l’unico involucro che potrebbe proteggerla. L
a droga ha il potere di scavare il corpo, affondare i denti nella carne e plasmare la materia, evaporare il pensiero e liquefare la coscienza.
Rimango con una profonda amarezza. Ma sono felice di aver portato a termine un romanzo così profondo e istruttivo.
Grazie Antonella per tutta la verità che porti nelle tue storie.
Lucy