Cosa si può scrivere di se stessi? Ma più nel dettaglio, cosa scrivere del se inteso come corredo genealogico, come base, substrato che assurge alla funzione di cellula ponte che viaggia nel tempo e collega noi con altre generazioni e di conseguenza con tutta l’umanità, in un comun denominatore fatto di identità umana, di appartenenza anche per chi crede di non essere parte di alcun mondo?
Michele Mari è un autore che ho incontrato di recente nelle mie letture per la prima volta. Sto seguendo un corso di scrittura sulle storie familiari presso la #scuolaholden che mi sta dando un sacco di spunti sui quali riflettere e tra le letture consigliate per affrontare il racconto di famiglia c’è Leggenda privata uscito con Einaudi nel 2017. Non lo avevo mai letto, mi sono sentita una gran capra, ho capito che ogni giorno scopro autori, temi, pubblicazioni e materie di cui non sospettavo minimamente l’esistenza, questo mi angoscia e mi rallegra al contempo. Cammino nel mondo inconsapevole, questa è la massima o il pensiero che mi accompagna da un po’ di tempo. Vorrei aver impiegato meglio il mio tempo, aver conversato con persone di cui mi interessava il parere, vorrei aver comprato più libri, più giornali, vorrei aver partecipato attivamente a più rassegne, festival, mostre d’arte. Potrei piangere e abbattermi all’infinito, si. Oppure prendere atto della finitezza del mio tempo e usarlo, come posso, per rimediare a un infinito che mi sfugge e che sarà sempre oltre le mie possibilità. Giuro che la smetto di cospargermi il capo di sale e di inginocchiarmi sulla cera o il contrario, insomma quella roba qui, che si capisce subito.
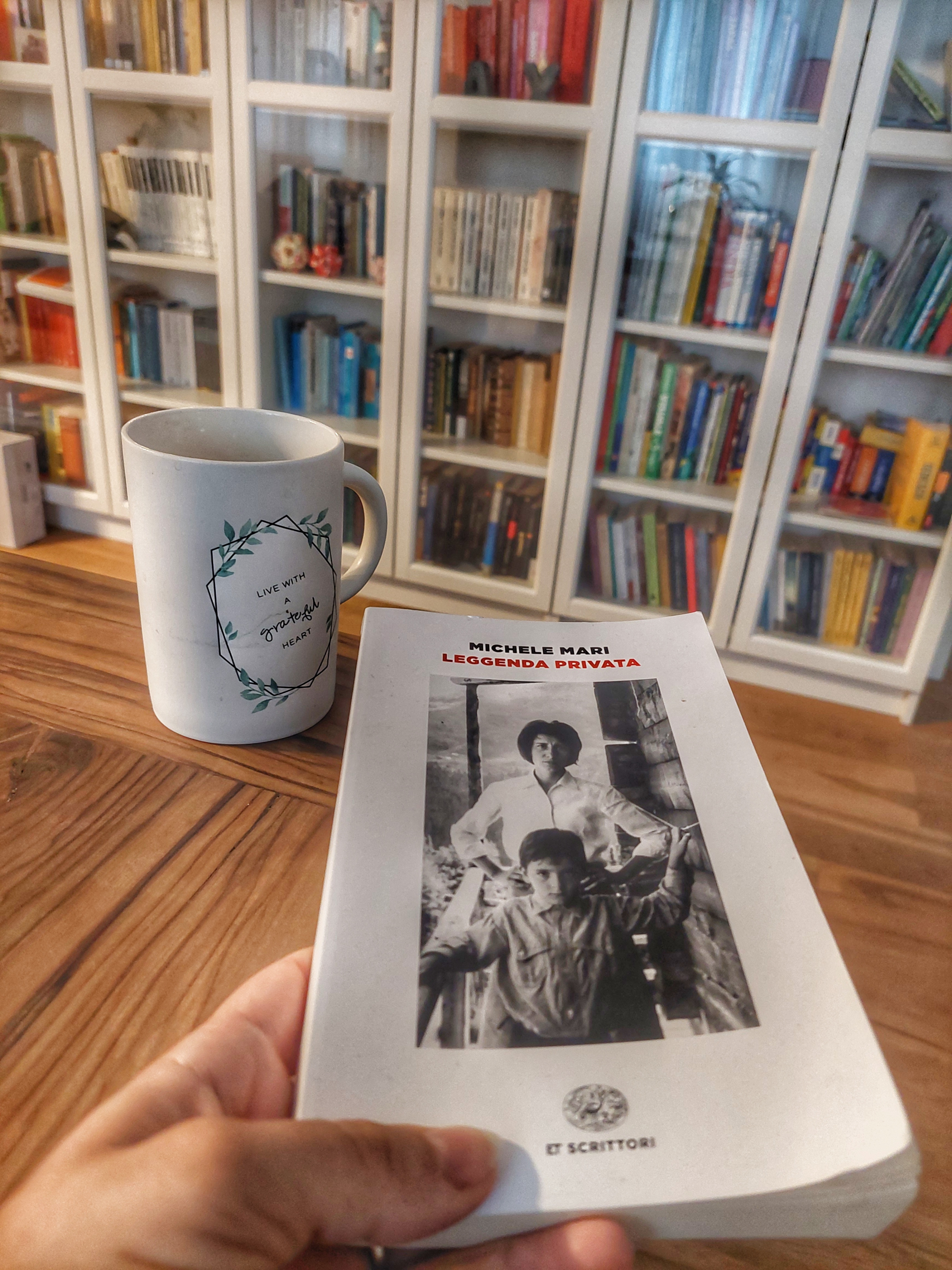
Mi è piaciuto Michele Mari perché, anche se con una complessità troppo artificiosa per i miei gusti, tratta la sua vicenda famigliare annotando, secondo il suo stile, ricordi, considerazioni e fatti oggettivi e innestandoli di manierismo, citazioni erudite, colpi di scena e molta umanità disperata. Trasforma quel che pensa in un tributo letterario, sembra sempre tendere alla citazione, a qualcosa che è già noto che fa parte della sua vita interiore, di un bagaglio che lo rende appunto Michele Mari e gli consente di buttare le zavorre e viaggiare col pensiero perché l’identità è salva. Tratteggia la sua infanzia come fosse un incubo, quale infanzia, dopo tutto non lo è e quale adolescenza non vi sfocia per propria stessa natura? All’inizio del racconto mi aspettavo qualche tragedia inconfessabile, qualche dolore sopito e che aveva seminato distruzione, morte e raccapriccio. Invece nel racconto di Mari c’è molta verità, una verità comune fatta di incontri, pensieri e speranze disattese, indifferenza e mutismo, fatta perciò di quello che accade in tutte le vite. L’escamotage di rendere se stesso bambino protagonista e narratore delle vicende avvicina il lettore, lo cattura e lo proietta alla scoperta dei meandri, delle gallerie oscure attraversate dal bambino durante la sua crescita innescando un processo di autoanalisi, anche se siamo credo tutti lontani anni luce quando guardiamo allo specifico universo del noi bambino. Nelle pagine di Leggenda privata ci sono molti dubbi infantili e molta confusione adolescenziale che sfociano poi nell’età adulta, pensieri ricorrenti e delusioni che hanno condizionato parte del suo modo di essere e di pensare.
Figlio di due menti creative, il padre designer di successo Enzo Mari e la madre, la disegnatrice e scrittrice Gabriela Ferrario. Entrambi i genitori soffocano in parte i desideri e le aspirazioni del giovane Michele ma al contempo ne amplificano il desiderio d’espressione, la genetica lo forgia, l’ambiente lo fortifica, le frequentazioni dei genitori e dei nonni che premono per coltivare i contatti con Eugenio e Salvatore Montale, con tanti artisti e letterati che disseminano la vita di questa famiglia di schegge creative, a volte impazzite. La madre prima del padre, una donna che poi scompare, fresca e vigorosa arrampicatrice di montagne insieme a Dino Buzzati, di lui ho comprato subito una sua raccolta di racconti, La boutique del mistero che riporta in copertina alcune sue illustrazioni. Ne parlerò in un prossimo articolo.
Parola, tratto e pensiero sono i tre elementi base combinati in molteplici e poliedriche sequenze con cui viene nutrito Mari, insieme al pancotto, qualche volta con l’olio per renderlo buono, dettagli, sparsi qua e la, ripetuti e che innestano un germoglio, ti fanno pensare.
Le figure dei genitori, amati, emulati e temuti, sono tratteggiate come quelle di due esseri umani complicati, resi con lo sguardo schivo e distante del figlio che li osserva, ne registra le ossessioni e le debolezze, le malattie vengono diagnosticate dal lettore e da Mari adulto, ma non c’è niente di strano, perché poi a ben guardare siamo tutti sul ciglio del burrone. La cinghia, dalla parte della fibbia viene nominata, i silenzi che tagliano a fette più deli giudici più taglienti. La totale mancanza di spazio, la claustrofobia emozionale in cui sembra crescere Michele Mari, soffocato dall’ego e dai pensieri dei genitori, è di certo l’incubo di cui lui vuole indicare le forme. Il mondo creato sembra un universo parallelo che si anima nella testa dello scrittore bambino e poi adulto mentre ripercorre i turbamenti di una percezione errata a tratti monca della realtà; ho trovato molto interessante il lavoro di ricostruzione operato da Mari che sembra indossare le vesti del bambino ma che in realtà non dismette lo stato di disillusione e distacco che anima tutto il romanzo.
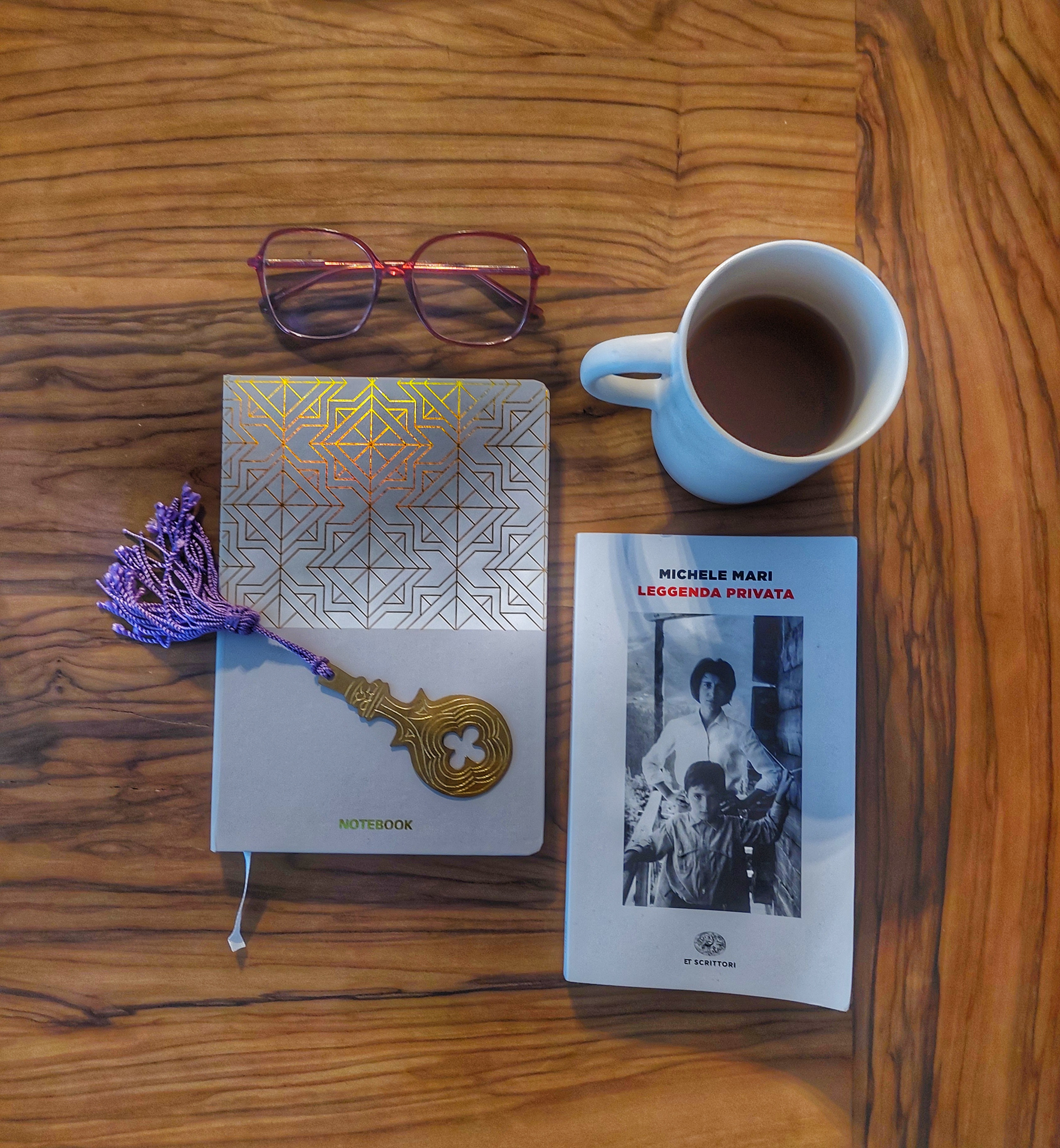
Onestamente non so se avrei scelto in autonomia di leggere questo romanzo ma sono molto grata al nostro insegnante di averlo indicato perché, sto scoprendo piano piano, le letture che si allontanano dal mio gusto mi restituiscono molto di più. Ritorno dal viaggio della lettura con un pezzo nuovo di me, come se avessi scoperto qualcosa che non mi aspettavo di avere, si accende un neurone sopito e da li riparto nuova e fresca.
Ottimo consiglio, grazie Matteo.
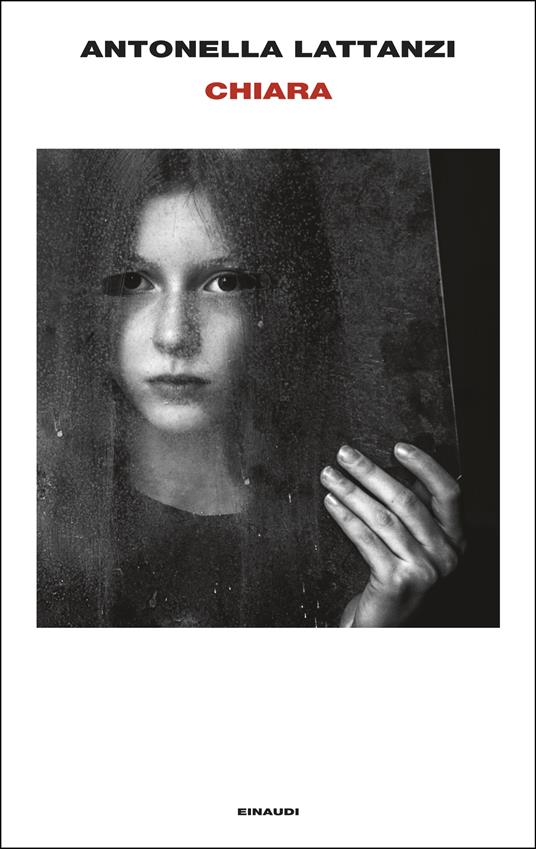
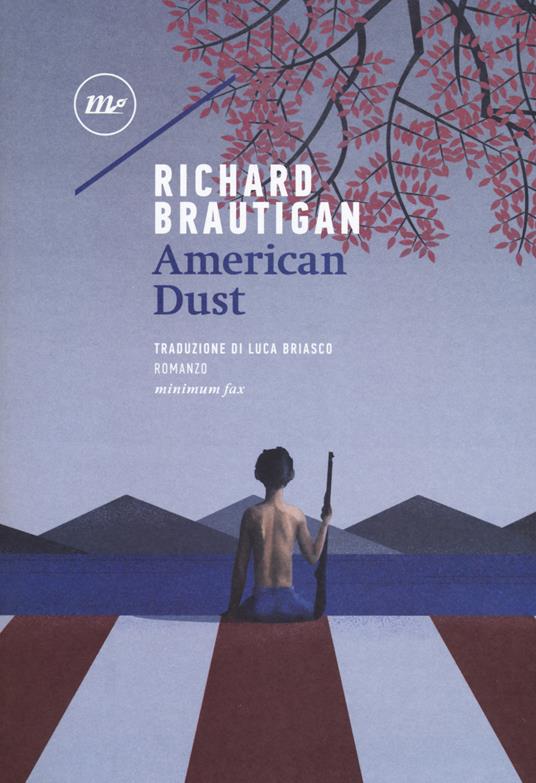
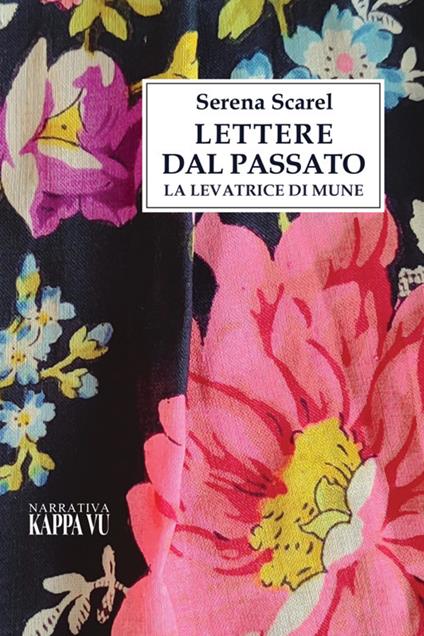
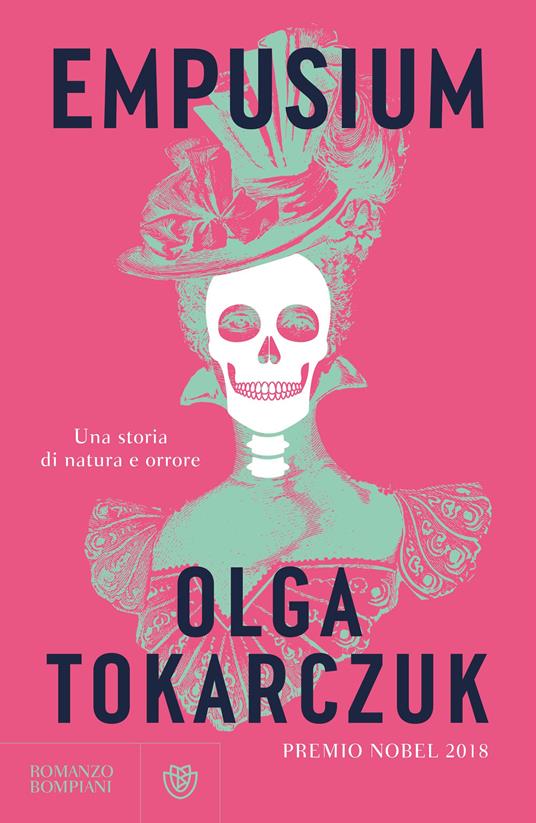
Really happy with my experience at debettvn. Deposits were smooth, and I cashed out without any problem. Highly recommended! debettvn