Vorrei iniziare a condividere, qualche volta un breve racconto, memoir o riflessione di quelli fermi nelle mie cartelle del pc. Piccoli esercizi di scrittura che devono essere intesi appunto come tali, imperfetti e probabilmente ancora acerbi ma che mi fa piacere condividere perché per me significano qualcosa e magari chi è in grado potrà darmi un suo riscontro. Buona lettura, spero.
Luciana Amato
A perpetua memoria.
L’odore della Fiat Cinquecento dei miei genitori è ancora nitido nelle mie narici: ci accompagnava al cimitero di Sant’Anna e oggi, che ormai sono adulta, se passo davanti a quel piazzale, quasi come un riflesso di pavloviana accezione, ne sento aleggiare ancora la sfumatura acidula, ingentilita da una nota di fiori recisi; quei fiori che, intuivo già allora, sapevano essere mezzi vivi e mezzi morti, in bilico tra noi e loro, i sepolti.
«Mamma! Apri la capotta che oggi non piove!»
La vettura era nera con i sedili tappezzati di velluto fiammeggiante. Ahimè, quando pioveva entrava sempre un poco d’acqua dal tettuccio flessibile e anche se i sedili erano stati rifoderati, un vago sentore di muffa già aleggiava fedele nell’abitacolo; nemmeno il prodigo Arbre Magique al pino mugo la spuntava. Quell’odore ti si insinuava sotto le unghie e tra i capelli, scemava un pochino appena si usciva dalla vettura ma in realtà nelle mie narici, già allora molto sensibili, qualcosa ne permaneva, uno spettro che mi seguiva puntuale, dopo quelle visite tra il grigio delle lapidi e il verde opaco dei cipressi.

Una volta al mese facevamo visita ai nostri morti. Noi bambini prendevamo questa incursione come una gita fuori dal mondo ordinario. La nostra infanzia era costellata da cose oscure che aleggiavano sulle nostre teste, spiegate a metà: erano quelle che ci piacevano di più. Sant’ Anna, con le sue statue di angeli piangenti, le lapidi scolpite con frasi tristi, le cappelle di famiglie prestigiose ma estinte, inglobava parte di quel mistero non svelato e ci calamitava come fa lo zucchero con le mosche.
Mamma imboccava la curva a gomito su Via Flavia e parcheggiava; tirava il freno a mano con un gesto secco, lui gracchiava in risposta. A quel movimento rapido del braccio, innervato di vene blu, un braccialetto fatto con maglie piatte, luccicava sul polso e poi, con un rimbalzo deciso, neanche a farlo apposta, tornava al suo posto.
Quel crack del freno ci riportava all’ordine. Io e mio fratello smettevamo di fare i nostri giochi e balzavamo in strada. Camminavamo a fianco di nostra mamma, trotterellando sotto il suo sguardo acuto, non le scappava un fiato. Di solito una sigaretta le penzolava da un lato della bocca, le nascondeva le pupille azzurre con volute fumose che salivano fino alla nuca e noi dietro come fantasmi, ci muovevamo circospetti, ospiti per qualche ora delle anime residenti in pianta stabile a Sant’Anna.
Al cancello del cimitero si acquistava un mazzo di garofani in una delle bancarelle disposte a raggera attorno al parcheggio, ognuna col nome di un fiore. Con un soldino si poteva prendere in affitto un secchiello dal custode, all’ingresso del cimitero. I secchielli erano come quelli per andare al mare, azzurri ma senza disegni, adeguati. Si riempivano d’acqua in prossimità della piazzola giusta, mamma sapeva i numeri di tutti i nostri morti. Mi domandavo che numero mi sarebbe capitato un giorno, chissà mi rispondo adesso e azzardo che forse è meglio, per ora, non sapere, anche se ci vorrei un bel sette in mezzo, si, il mio numero ricorrente.

La tomba che mi piaceva più di tutte era quella della nonna di mio padre, Antonietta. Per raggiungere il luogo dove era stata deposta dovevamo risalire una piccola erta sterrata bordata da alti cipressi, pietre carsiche, cespugli d’erba incolta che si tendevano verso di noi come antenne in cerca di segnale. Così si arrivava in un campo libero, come un prato, dove tutte le sepolture erano allineate, una a fianco all’altra, come a farsi compagnia. Non erano tombe dentro loculi di cemento ma le ultime bare poste sotto la terra grassa del colle. Quella poca distanza tra noi e il corpo di nonna Antonietta mi impressionava, era una tangibile prova del fatto che siamo vivi e poi morti, corpi abbandonati dalla vita e sepolti per seguire un nuovo corso fatto di terra, putridume e dimenticanza e questo aveva un potere enigmatico su di me che osservavo vivere e morire ogni giorno creature come le mosche o le formiche o i ragni nel giardino di mio nonno, mi chiedevo se fosse lo stesso tipo di morte, anche se loro non avevano sepolture e forse nemmeno si accorgevano di essere vivi e poi morti, ma io dentro la testa di un lombrico, mica ci potevo entrare. Erano solo teorie.
Gli oggetti che, durante quei tragitti silenziosi, trovavo più interessanti erano le foto: fissavo i lineamenti, le acconciature, gli abiti con colletti lunghi e appuntiti, fermi agli anni settanta, in bianco e nero e poi via via a colori, sbiaditi dal sole. Ricordo ancora alcune di quelle facce inconsapevoli. Loro non immaginavano che proprio quel sorriso, in quel minuto di quel giorno sarebbe stato stampato, a perpetua memoria, anche sulla loro lapide. Forse, a saperlo, si sarebbero fatti più pensosi per darsi un tono, avrebbero interpretato un ruolo, quello che pensavano di aver avuto in vita. Forse, o forse no.
Leggevo le date. Enumeravo le età. Trasalivo quando le tombe erano di giovani poco più grandi di me. Mi innamoravo.
Dove stava la bisnonna Antonietta erano morti quasi tutti vicino al mio anno di nascita, il 1979. Pensavo che per loro quell’anno non aveva girato bene. Intuivo che c’è chi arriva e chi parte, i primi per un lasso di tempo tra i due trattini i secondi, per sempre: questo infinito susseguirsi di giorni mi risultava un mistero oscuro e quieto, che aspettava solo di essere svelato.
Con qualcuno dei morti intorno a nonna Antonietta ero entrata in confidenza. Mi ero immaginata le storie delle loro vite e in parte con la nonna andavo a trovare anche loro; mi domandavo cosa potessero aver fatto o pensato in quelle settimane di intermezzo. Ero sicura ci fosse una vita nascosta sotto quel brulicare di terra e foglie, tra le radici di rododendri e di gardenie piantumate sulle sepolture, eppure quella vita restava muta anche sotto le spinte del vento gelido che la sferzava e incitava senza mai ottenere risposta.
Dove i fiori erano secchi e le erbacce avevano preso il sopravvento, facevo la faccia contrita che avevo provato a casa e poi scuotevo il capo in segno di disapprovazione. Più che altro mimavo lo sdegno degli adulti. Quasi tutti i bambini sono empatici, io in questo avevo un talento speciale. Di solito ero molto solerte nell’adeguarmi alle situazioni, per quieto vivere accettavo il punto di vista dei grandi perché in loro avevo riposto la mia fiducia, poi ci sarebbe stata una lunga fase di guerre più o meno sotterranee, allora però, al tempo delle visite cimiteriali, la mia persona finiva dentro di me e fuori invece ero ancora proprietà altrui, condizione alla quale mi adattavo perfettamente in quel contesto. Io ero una tomba.
Terminata la salita, ci allineavamo in un minuto di silenzio, immobili. Poi iniziava tutto: io e mio fratello diventavamo “gli aiuti”. Passami il secchio. Passami la spugna. Laviamo il vaso. Riempiamo di acqua fresca il vaso. Strappiamo le erbacce intorno alla croce di legno, senza sporcarvi tutti con la terra! Adesso non toccate niente che vi bagnate. Passami i fiori freschi. Tieni i fiori secchi che poi li buttiamo. Facciamo la preghiera.
Il momento della preghiera era il fulcro dell’attività. Si giungevano le mani e con il capo chino si stava in silenzio, ognuno per sé. Talvolta si ascoltava il dolore altrui. Io dicevo un Ave Maria o un Padre nostro, solo quelle che conoscevo meglio: ero una bambina pigra, dalla memoria debole. Di solito a metà, stanca di recitare a papera, mi lasciavo andare in una composizione libera, raccontavo qualcosa a nonna Antonietta, anche se non l’avevo mai vista se non in foto. Era una donna dalle labbra molto carnose, le guance rotonde e gli occhi grandi e scuri, assomigliava a qualcuno, forse anche a me; c’era qualcosa nel suo sguardo che la rendeva familiare, parte di noi, una antenata carnalmente viva perché ancora contenuta nella memoria corporea della sua discendenza. Mi piaceva raccontarle qualcosa, ammettere di avere sulla coscienza un peccatuccio, che tanto lei ci vedeva tutti. Poi mi consolavo, lei comunque essendo bisnonna mi aveva già perdonata e magari da lassù o da laggiù chissà, mandava qualche bacetto.
A memoria di quei giorni, ammetto di non visitare i miei morti perché sempre meno vita mi separa da quei posti e loro mi vedono, perciò finché vivo li porto con me, altrove.
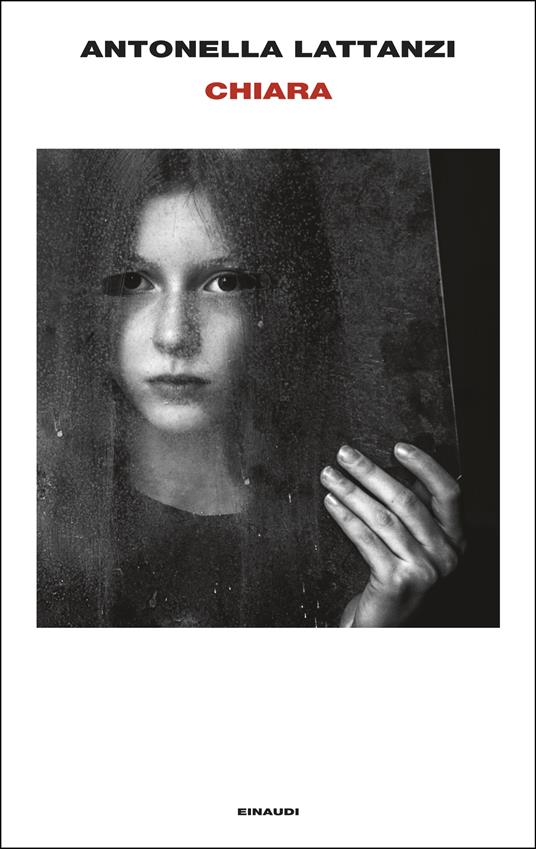
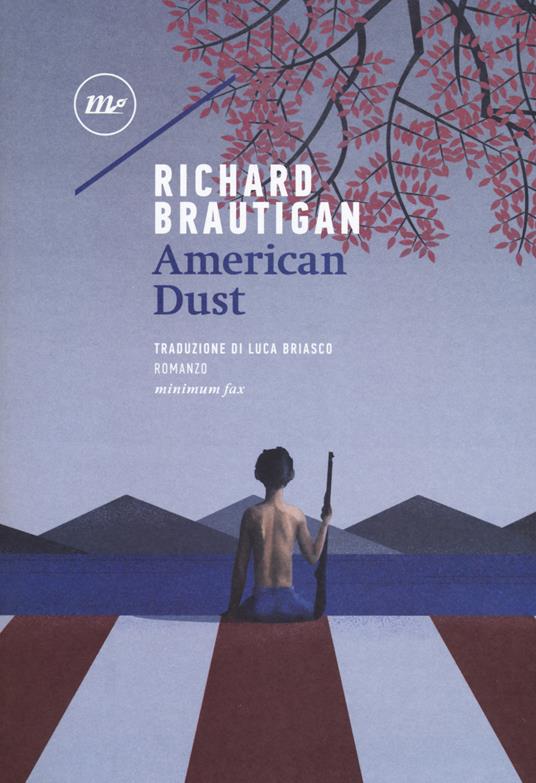

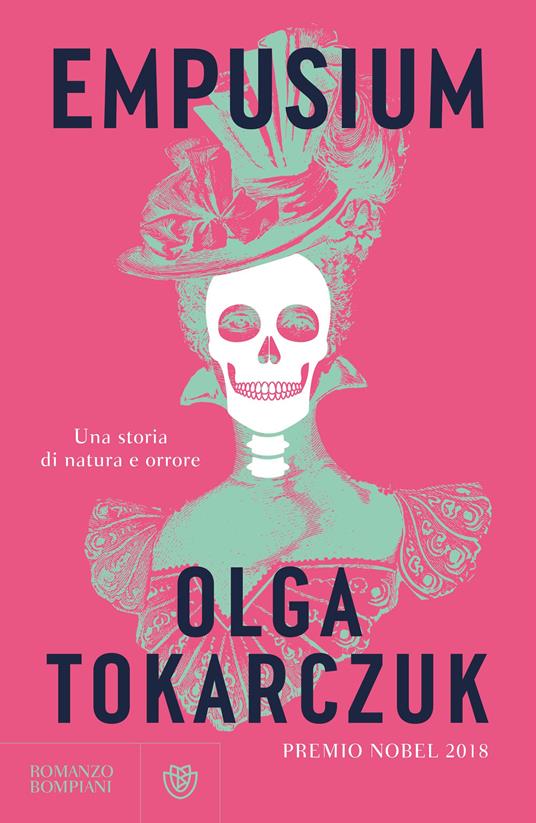
Ti aspetto 😊♥️🐈⬛
🙏🩵
Betfiery44… that name sounds hot! Let’s hope my winnings catch fire too! Ready to win big! Join the heat at betfiery44!