Gli Adelphi, 204 pp. – Traduzione di Milena Zemira Ciccimarra
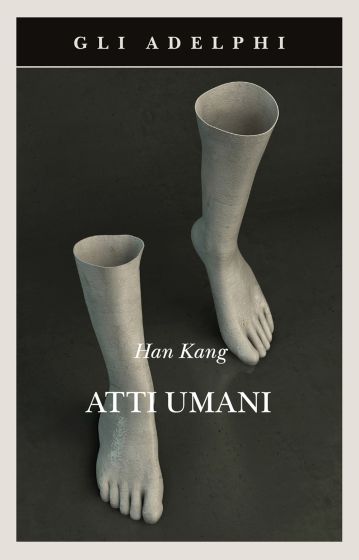
Un romanzo necessario sulla brutalità del potere e la dignità dell’umano
Quando la letteratura dà voce all’indicibile
Han Kang, scrittrice sudcoreana insignita del Premio Nobel per la Letteratura nel 2024, è un’autrice le cui opere, fin dalla lettura de La vegetariana (Adelphi, 2016), hanno saputo stregare lettori in ogni parte del mondo. La sua scrittura poetica, scarnificata e fortemente evocativa, riflette un pensiero lucido e coerente che affonda le radici nell’analisi della natura umana, interrogandone ogni sfumatura. Han Kang scruta a fondo lo spazio tra corpo, memoria e trauma, spingendo il lettore a fare altrettanto.
Con Atti umani, la sua voce si fa ancora più ferma e urgente. In questo romanzo polifonico e straziante, Han Kang riapre una delle ferite più profonde della storia sudcoreana: il massacro di Gwangju del 1980. Un capitolo drammatico a lungo ignorato, soprattutto in Occidente, al quale l’autrice sceglie di dare voce.
Un romanzo costruito sul trauma: voci e corpi
Il romanzo è un racconto corale dei fatti avvenuti durante e dopo il massacro di Gwangju, una rivolta popolare sedata brutalmente dall’esercito sudcoreano il 18 maggio 1980. Tutto comincia in una palestra comunale gremita di cadaveri, i cui corpi saturano l’aria di un “orribile tanfo putrido”. Il sopruso e la violenza innescano un processo straordinario di ribellione.
La struttura di Atti umani è divisa in sette capitoli (sei capitoli e un epilogo), ciascuno dei quali dà voce alle esperienze vissute da un protagonista diretto o indiretto del massacro. È una progressione temporale che ha inizio nel 1980 e giunge fino al 2013. Conosciamo il quindicenne Dong-ho, che cerca un amico scomparso ma si ritrova a contare cadaveri e a prendersi cura dei corpi. Conosciamo Eun-sook, la redattrice che ha sperimentato la censura e le torture. Ci sono le storie di un prigioniero sopravvissuto, di una giovane operaia, della madre di Dong-ho, e infine quella della scrittrice stessa, che racconta il suo lavoro di documentazione e il perché ha sentito il bisogno di scrivere questo libro.
La narrazione è un coro polifonico dei vivi e dei morti, dove le voci si intrecciano in diversi piani temporali. Il giovane Dong-ho funge da filo conduttore e collante per tutte le storie, un ragazzo che, non potendo recuperare il corpo dell’amico, sceglie di restare in mezzo alla carneficina per onorare le vittime. Han Kang utilizza anche la seconda persona singolare (“tu”) per rivolgersi a Dong-ho, una scelta che mira a far sentire la presenza del defunto e a coinvolgere intensamente il lettore, quasi a renderlo complice e testimone.
Durante tutta la narrazione si intravedono corpi e parti di essi. I corpi, la materia, paiono la testimonianza di ciò che resta, privato di tutto, quando la dignità e lo spirito vengono annientati. L’interrogativo di Han Kang è tremendo: possono le anime continuare a provare dolore? Le anime sperano di poter chiudere gli occhi, ma non possono: sono depositarie della verità. E pur in quel magma tra orrore e smarrimento, sono gli oggetti più banali, i piccoli atti di gentilezza che possono rendere l’esistenza tollerabile.
L’arrogarsi il diritto di violare la vita è il gesto più ingiusto e orribile. Mutilare e cancellare l’identità, spazzarne la memoria e togliere ai cari un resto sul quale piangere si muta nell’orrore più grande. Come recita un passaggio toccante, si cercava l’inno nazionale o un minuto di silenzio “per far si che i cadaveri per cui cantavamo fossero qualcosa di più di pezzi di carne macellati”. “Non c’è modo di tornare al mondo precedente alla tortura. Nessuna strada per il mondo precedente al massacro”. Il tema del corpo che subisce violenza è centrale per Han Kang.
Affrontare l’orrore, trovare l’umanità
Han Kang denuncia un episodio di estrema violenza e crudeltà, ambientato in una palestra di Gwangju. Le vittime sono ragazzi normali, impreparati a ciò che vivranno. L’odore della violenza e della morte distruggerà qualcosa dentro ognuno di loro, non torneranno mai più indietro nè i morti nè i sopravissuti.
L’autrice, nata a Gwangju nel 1970 ma trasferitasi a Seoul prima del massacro, racconta di come la sua famiglia abbia vissuto a lungo la sensazione che “qualcuno al posto nostro si fosse fatto male”. Non decise subito di scrivere del massacro, ma l’idea emerse interrogandosi sulla “difficoltà dell’abbracciare la vita” e sulla “persistente domanda sulla natura umana”. Questo l’ha portata ad affrontare il massacro, anche se indirettamente vissuto. Scrivere il libro è diventato necessario, altrimenti “non sarei potuta andare avanti”.
La scrittura di questo romanzo è stata un’esperienza emotivamente devastante per l’autrice. È stata un’esperienza “travolgente”, in cui ha sentito di doversi “rompere e smantellare” per poi “ricostruire”. Ha pianto quasi ogni giorno. Sorprendentemente, anche i lettori hanno riferito di aver provato un dolore fortissimo. Questo l’ha portata a chiedersi perché proviamo un dolore così intenso di fronte a scene di orrore, “quanto crediamo nell’umanità, quanto amiamo l’umanità”.
Han Kang non si è limitata a indagare gli eventi di Gwangju, ma ha studiato molti episodi di violenza nella storia, sia in Corea che all’estero. Si è sentita “scossa nella sua fede nell’umanità”. Eppure, nella brutalità, ha anche incontrato atti di incredibile umanità. Ricorda le foto viste da bambina: volti delle vittime uccise dai soldati e, accanto, infinite file di cittadini che donavano il sangue per i feriti. Questo contrasto, questa “contraddizione inspiegabile” tra l’uccidere e il salvare, è ciò che ha voluto esplorare. Si è spinta per “trapassare” questa contraddizione inconciliabile, desiderando passare “dalla crudeltà umana alla dignità umana”. Questo processo l’ha cambiata profondamente, influenzando anche le sue opere future. Non è stato un sollievo, né ha reso le cicatrici meno dolorose; semplicemente, l’ha trasformata.
Speranza e Memoria
Il tema della violenza è doloroso ma essenziale per l’autrice. Si concentra sulle persone che, di fronte a una violenza terrificante, hanno cercato di agire. Vuole capire “come si resta umani”.
Nonostante l’orrore, il libro celebra anche la memoria e la resistenza. Gwangju non è solo un massacro, ma anche una “resistenza” e una “assoluta comunità”. In situazioni di isolamento e violenza assoluta, le persone hanno condiviso sangue e cibo. È come se nei luoghi di maggiore brutalità emergesse una forte reazione, una “fervida” espressione dell’umanità. Come disse un autore citato da Han Kang, “la caratteristica della speranza è che nasce nell’oscurità”. A volte, di fronte alla disperazione, bisogna “trovare la speranza anche se è fragile” e, anche se difficile, dobbiamo “immaginare la speranza”.
Nel romanzo, le candele hanno un significato profondo: accese all’inizio per onorare i morti, e alla fine sull’albero dove è sepolto Dong-ho. Le candele rappresentano un “lutto profondo”, l’atto di “fare del proprio meglio”. Simboleggiano il tentativo di andare “dall’oscurità alla luce”, di “attraversare la crudeltà”. Sono “qualcosa che arde, qualcosa di caldo”.
Atti umani non è solo un libro-inchiesta; è una narrazione polifonica che, pur nella sua crudezza e descrizioni dell’orrore, è permeata da punte di delicatezza e lirismo poetico. Non cancella il trauma, ma aiuta a comprenderlo, a smuovere le coscienze. Il trauma di cui parla Han Kang è reale, e la sua scrittura diventa un’esperienza per il lettore, spingendolo a interrogarsi sul presente e sul futuro. La letteratura, per Han Kang, “non è una risposta, ma il processo di seguire una domanda fino alla fine” e ad aprire nuove domande.
Il libro, nella sua intensità, sembra quasi un’esperienza fisica per l’autrice e per chi legge. È un’opera necessaria che ci costringe a guardare in faccia l’indicibile e a riflettere sulla persistente forza degli “atti umani” anche nell’oscurità più profonda.
Trovi qui la mia recensione di L’ora di greco sempre della stessa autrice.
AUTRICE:

Han Kang (nata nel 1970) è una scrittrice sudcoreana di fama internazionale, vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura nel 2024, riconoscimento che l’ha resa la prima autrice asiatica ad ottenerlo. Figlia dello scrittore Han Seungwon e studiosa di letteratura coreana alla Yonsei University, ha iniziato la sua carriera come poetessa, sviluppando uno stile unico, intenso, poetico e sperimentale. Le sue opere indagano domande universali sul senso dell’esistenza, la sofferenza e l’amore, confrontandosi in particolare con i traumi storici ed esponendo l’intrinseca fragilità della vita umana, ed esplorando le connessioni tra corpo e anima, e tra vivi e morti. Già vincitrice dell’International Booker Prize nel 2016 per il suo romanzo La vegetariana, Han Kang è pubblicata in Italia da Adelphi e la sua prosa continua a toccare temi fondamentali dell’esperienza umana con straordinaria profondità.
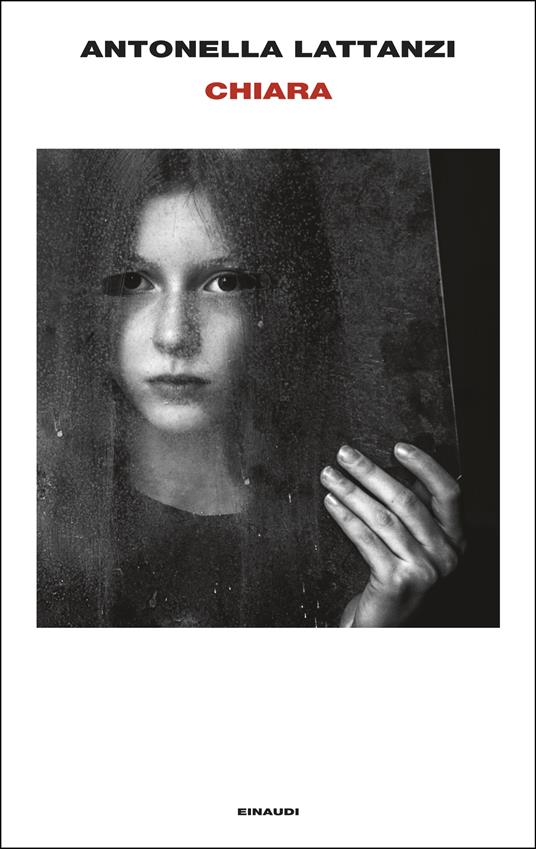
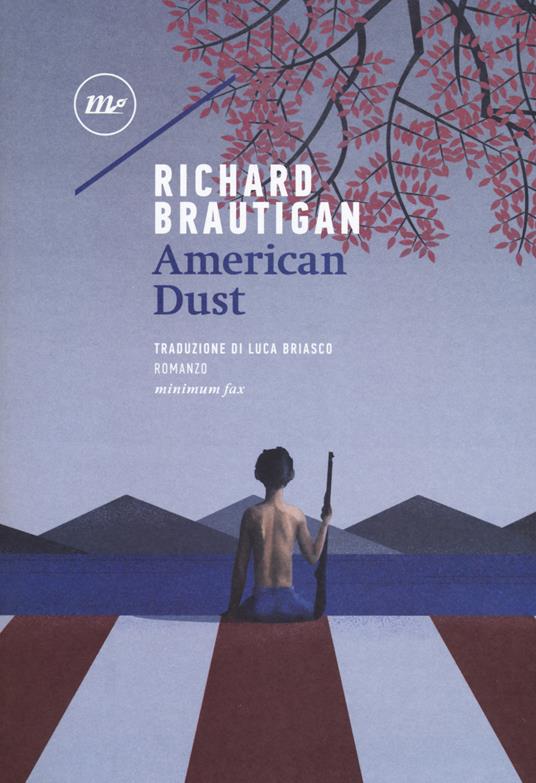
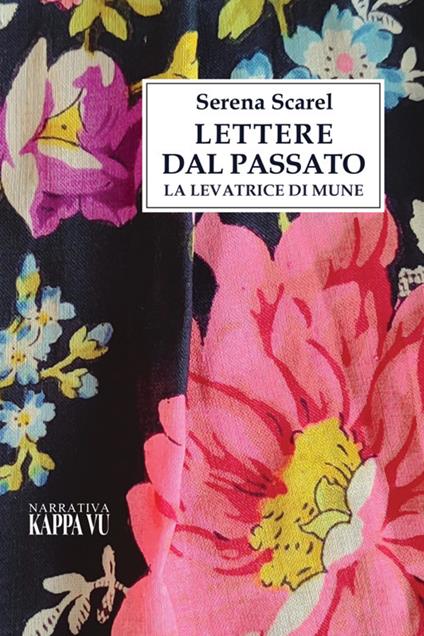
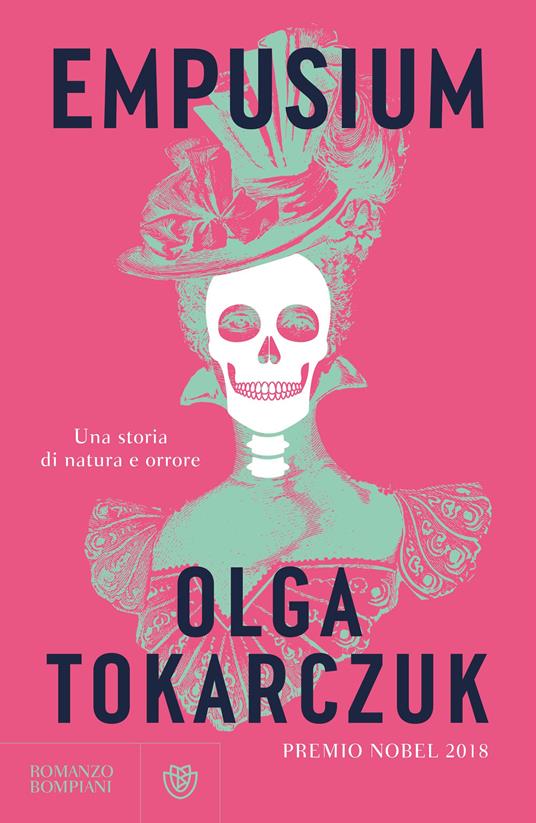
Yo, wanted to chime in about 66win9. This site is decent. They have a good variety of games, and navigation isn’t too bad either. Bonus structure isn’t the best, but it is functional. Worth a check on your own accord 66win9.